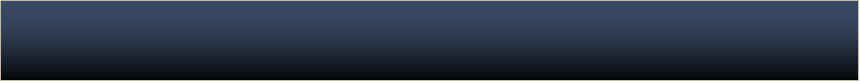
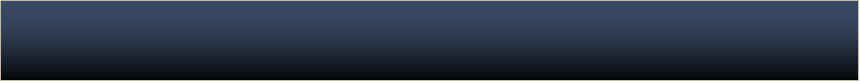

![]()
![]()
PARLIAMO DI TEATRO , AL VOLO
Novembre 2004
Parliamo di Teatro , al volo
![]()
Il teatro affonda le sue radici nell’antichità. In età arcaica greco-romana, l’edificio teatrale consisteva, per i Greci, in un anfiteatro a gradinate; a fronte degli spettatori sorgeva una costruzione (la scena) la cui facciata serviva da sfondo all’azione. Fra scena e teatro, s’apriva uno spazio destinato al coro, circolare o semicircolare. Sempre in età arcaica, a Roma il teatro era formato dalla scena composta in tavole di legno, approntate per l’occasione, poi smontate o demolite; solo eccezionalmente si costruirono scene in muratura, nei primi decenni del II secolo a.C., destinate ad essere in ogni modo demolite.Il pubblico assisteva alla rappresentazione stando in piedi, i senatori alla rinfusa con il popolino.. Più tardi, furono ricavati, di fronte alla scena, dei sedili di legno, e si stabilì per legge che gli appartenenti all’ordine senatorio sedessero nelle prime file. Il primo teatro stabile di pietra, fu costruito nel 55 a. C. da Pompeo, che ne ebbe l’idea a Mitilene, e fece eseguire la pianta di quel teatro, proponendosi però di costruirne uno, simile sì, ma più grandioso, che sorse nel Campo Marzio. Sotto Augusto seguirono il teatro di Marcello, i cui lavori erano già stati iniziati da Cesare e furono ultimati nell’11 a.C., e il teatro di Balbo, presso il Tevere. L’uno e l’altro furono inaugurati nel 13 a.C. Ma il teatro di Pompeo rimase, in Roma, il più grande di tutti. In ogni modo, sino agli ultimi anni della Repubblica, si assisté ad una strage di teatri che nascevano per essere distrutti. La scena romana, era strutturata in modo che sul palcoscenico ci fossero tre porte: una centrale, e due laterali. Esse servivano, generalmente, come ubicazione di tre abitazioni: la centrale poteva fungere da entrata di un tempio o di una casa patrizia, mentre le altre due erano destinate ad altre situazioni più o meno popolari. Gli attori portavano calzari e recitavano con maschere sul volto, utili anche per amplificare la voce oltre a comunicare “l’anima” del personaggio. I Romani, che pur avevano appreso l’arte teatrale dal mondo classico greco, per molto tempo non adottarono teatri stabili in muratura. I tre generi del teatro classico antico furono: tragedia, commedia e dramma satiresco. Per il primo, in Grecia, scrissero: Eschilo, Sofocle ed Euripide. Per il secondo genere, Aristofane e Menandro. A Roma, Seneca scrisse tragedie, Plauto e Terenzio commedie. Seguirono, dopo la caduta dell’impero romano, secoli bui. Nel medioevo si sviluppò il dramma liturgico-religioso, rappresentato in chiesa ed, in seguito, sul sagrato e nelle piazze, interpretato da dilettanti (il professionismo nacque a Roma) od organizzato dalle corporazioni artigiane. Bene, dopo queste notizie nozionistiche sulla struttura e gli autori del teatro d’origine, parliamo di chi fa teatro. L’interpretazione è un termine che comunemente indica la maniera particolare in cui un attore sostiene la propria parte; in un’accezione più specifica, indica la realizzazione scenica che un regista compie di un testo letterario designando quindi sia la parte, sia la particolare inflessione cui il regista sottomette il copione e, con esso, il lavoro evocativo degli attori unitamente alla dinamica corporea e fisionomica, non tralasciando la resa visiva (scenografia, luministica, costumistica e musicale) dell’ambiente in cui l’azione teatrale si svolge. Naturalmente il rapporto fra il testo e la sua concretizzazione è stato, ed è, al centro di una discussione costante: filosofi, teorici del teatro e registi hanno, infatti, giudicato la parola scritta come valore principale, cui l’interpretazione deve sottomettersi; anche in uno sforzo di fedeltà filologica. Altri, hanno invece sostenuto l’autonomia relativa dell’interpretazione come insieme d’invenzioni, che integrano e valutano il testo. Tra quanti si sono fatti portavoce della prima tesi, si ricordano: Antoine, Zola e Stanislavskij. Quelli per la seconda tesi, si possono citare: Appia, Craig, Brecht, per il quale l’attore stesso si fa giudice e commentatore dell’opera. In ogni caso però, il regista teatrale, la cui figura nacque intorno ala fine dell’800, si pone come intermediario tra autore e spettatori. Detto questo, resta da analizzare la prestazione specifica che l’attore compie nell’ambito della rappresentazione: la recitazione. Il termine recitazione, che nell’accezione italiana rimanda in senso stretto all’arte del dire (del dire a memoria) ed al modo in cui la declamazione di un testo è espressa, nelle altre lingue europee è composta etimologicamente da due concetti fondamentali: giuoco e azione. Già in questa ricchezza e ambiguità di significati, è preannunciata la complessità e ambivalenza che il termine ha assunto, e può assumere, nella storia del teatro. Aristotele pose il problema del rapporto fra l’attore e il personaggio se, vale a dire, sia necessario che gli attori “vivano” tutta intera l’azione come se fossero essi stessi personaggi viventi, e se sia più congeniale all’attore la versatile genialità o il temperamento esaltato. Per avere una completa definizione delle tecniche di recitazione proposte dai comici, bisogna arrivare al Goldoni che, con la sua riforma del teatro, formulò fondamenti indispensabili per una buona recitazione: il garbo e la naturalezza. Il che significa rinunziare, sulla scena, agli stereotipi cui va legandosi la recitazione, sia alle mirabolanti prodezze personali degli attori. Col definirsi della teoria secondo la quale ciò che dà fondamento al teatro è un repertorio di tesi cui l’attore si fa tramite verso il pubblico, la recitazione si pose sempre meno come possesso di un linguaggio espressivo autonomo, più o meno rigidamente codificato, e sempre più come interpretazione del testo; interpretazione che ha il proprio focale nel rapporto con il personaggio. I grandi attori dell’Ottocento, impostavano la loro recitazione dando al pubblico l’impressione di costruire la propria personalità e quella del personaggio. S’andavano delineando sempre più le due principali vie della recitazione: quella dell’immedesimazione, che travolge l’attore e il pubblico nell’equivoco di poter superare il momento della finzione e, dall’altra, quella del naturalismo a tutti i costi, nell’illusione che la semplice adesione al naturale possa essere sufficiente a creare il fatto teatrale. Agli eccessi di queste due tendenze risposero, da un lato, Lessing il quale, partendo dal presupposto che il compito dell’attore non è solo imitare la natura ma trasmettere la poesia, insisteva sulla necessità della qualità e preparazione tecnica dell’attore stesso, considerando le condizioni necessarie affinché la recitazione risponda al suo mandato. Dall’altro lato, interviene Diderot con il suo “paradosso sull’attore”, riprendendo la questione se l’attore debba o no “sentire” le passioni del proprio personaggio. Egli sostenne che l’attore è veramente grande quando è privo di sensibilità e in grado di dirigere il proprio corpo, come il burattinaio dirige il burattino. La recitazione nel XIX secolo, rimase, in linea di massima, improntata sulla forza e le complessità delle passioni che l’attore “sentiva” e riusciva a trasmettere. Il grande attore romantico, univa alla sensibilità un patrimonio tecnico che gli consentiva di arricchire, in ogni versante, lo spettacolo. Gli erano richieste prestanza d’aspetto e sicurezza nel portamento, voce bella e profonda: un insieme di qualità nelle quali non è difficile ravvisare i presupposti del passaggio dalla figura del primo attore a quella del mattatore, fino ad arrivare a quella dell’attore personaggio e del divo. Si deve a G. Modena una grande riforma della recitazione: egli sostenne l'esigenza di un ritorno alla spontaneità e alla “verità”, affermando che non si debbano imporre ai giovani attori modelli passivi da imitare, ma bisogna arricchire la personalità stimolandola, e portarla all’affermazione. Paradossalmente, questa riforma introduceva i principi delle scuole di recitazione nascenti. In esse furono raccolti ora l’uno, ora l’altro aspetto basilare della recitazione, nelle varie epoche e nei diversi stili. Il tutto, fuso in una concezione di educazione globale rivolta alla sensibilità: ogni materia d’insegnamento, dalla dizione alla musica, al mimo, era volta ad arricchire l’attore sviluppandone la personalità e la duttilità, senza dare un preciso indirizzo tecnico. Di fatto, però, l’educazione alla recitazione si risolveva spesso nell’abilità a padroneggiare le manifestazioni esteriori dei sentimenti, finendo quindi nel cliché e nella vuota retorica, perdendo di vista la tanto cercata “verità”. Sensibile a questo problema, sul finire dell’Ottocento, Stanislavskij (attore e regista russo) sistematizzò e innovò le tecniche di recitazione. Al centro pose l’universo psichico dell’attore, opponendo alla irrisolta questione della naturalezza nella finzione teatrale, la concezione del “realismo psicologico”. Egli allenò l’attore a “vivere” la sua parte cercando i punti di contatto psicologico con il personaggio, privilegiando il momento interiore ed eliminando così, ogni artificio retorico. Il metodo Stanislavskij domina nella definizione di recitazione del Novecento, accanto a quello di Brecht( regista , autore tedesco) che, pur distaccandosene, specie nelle conclusioni dei suoi seguaci, non nega il suo debito con il regista russo. Brecht, riscoprendo l’efficacia della recitazione orientale, che trova nel distacco formale il massimo di espressività, affermava un tipo di recitazione volutamente amplificata e “straniata”, in cui l’attore assume un ruolo critico nei confronti del personaggio e dell’azione: non più immedesimazione cieca, ma riflessione di fronte alle passioni, e ricerca non della naturalistica imitazione del reale, ma di quelli che sono i fondamenti e le cause della realtà. Il modello della recitazione orientale è assunto, nel Novecento, come antitesi alla recitazione dell’attore fine dicitore, l’attore che sa solo parlare ed il suo corpo è ridotto al mutismo.. Il recupero di tale tradizione è compiuto o sulla scia di Brecht, o sulla concezione rituale dell’azione drammatica in cui la recitazione in sé, perde valore, o perché la presenza dell’attore è in uno dei tanti elementi che concorrono a tale rituale, o perché non ha più senso parlare di tecnica di recitazione in un teatro che si sottrae ad ogni definizione tradizionale. A mio parere, un attore è tale quando lo è in modo viscerale, genetico… deve possedere quel qualcosa in più dentro di sé, una predisposizione d’animo, uno spirito illuminante. Certo le scuole, le tecniche e le teorie accrescono, formano e plasmano l’attore ma, se non esiste la materia prima su cui “costruirci” sopra, credo che la mediocrità ne sia il risultato finale.
Gianpiero
Dèlmati